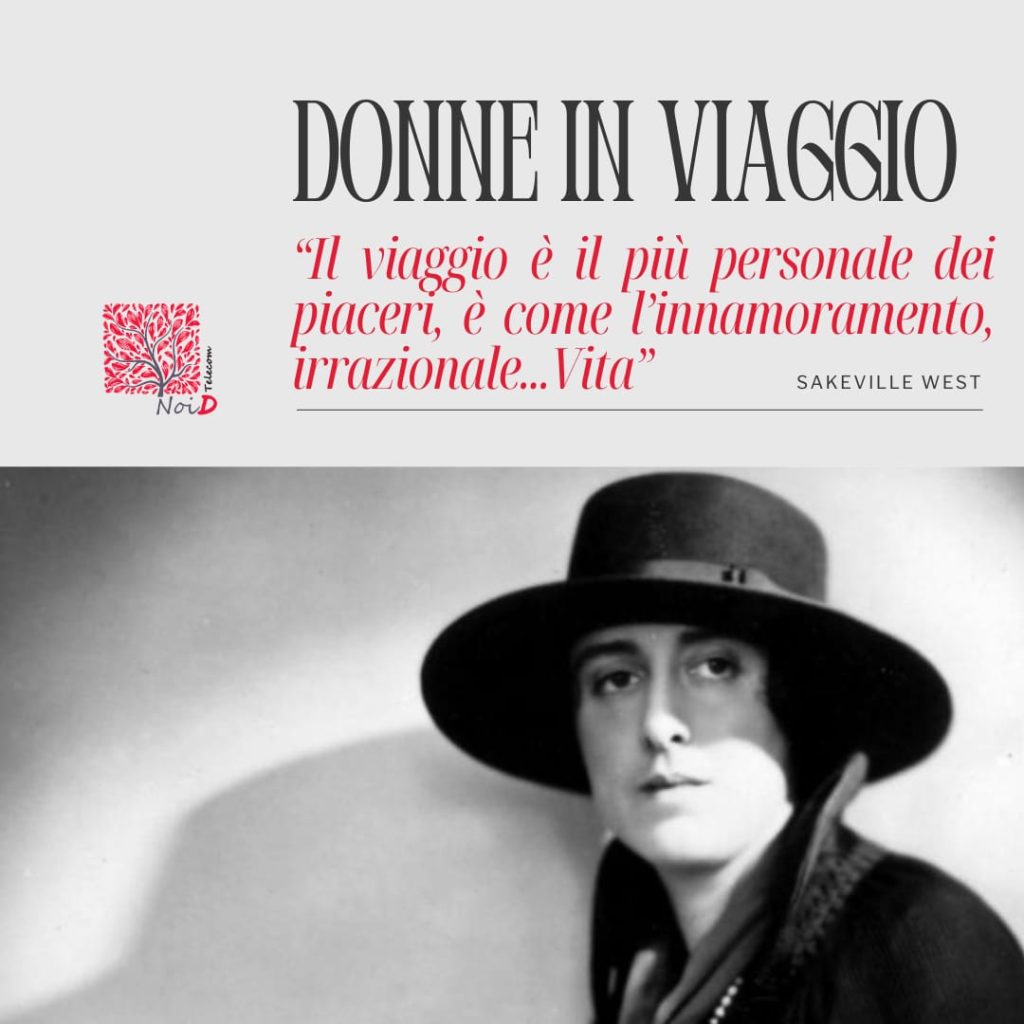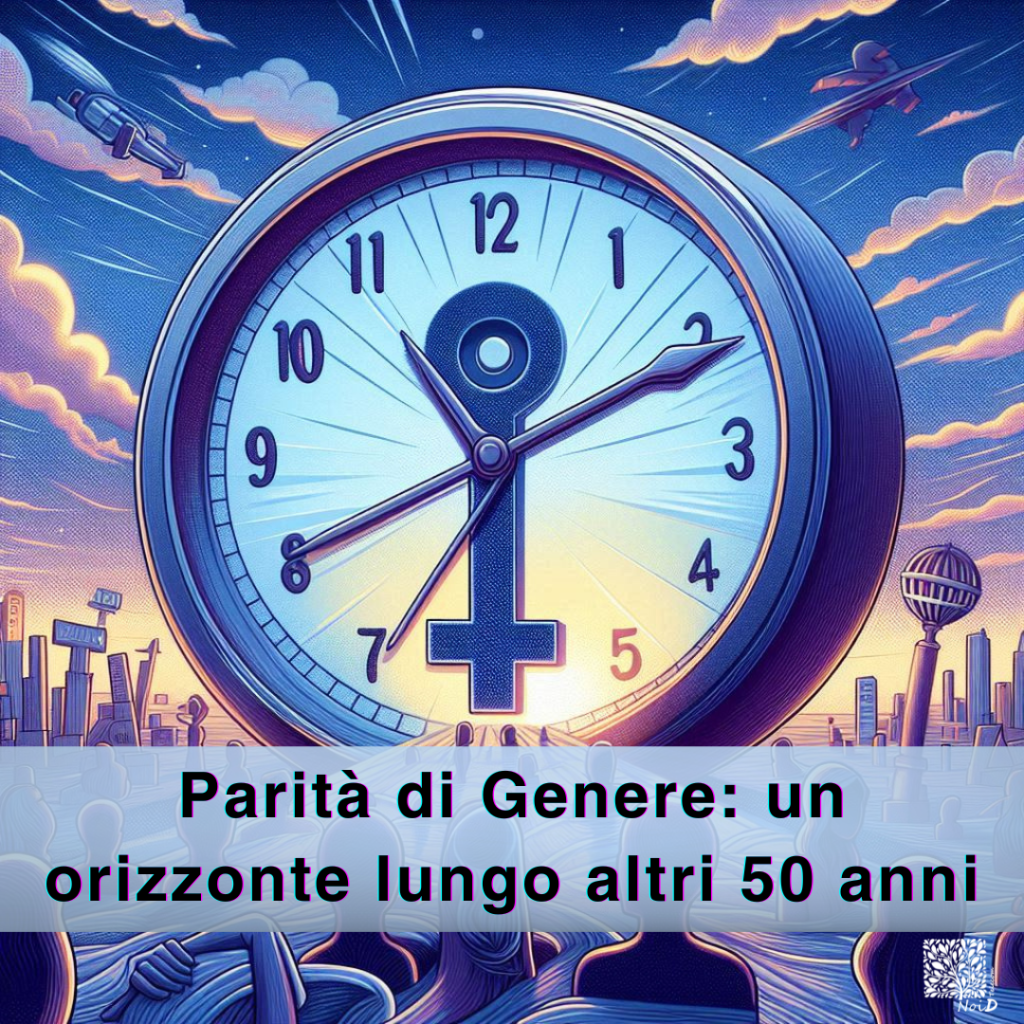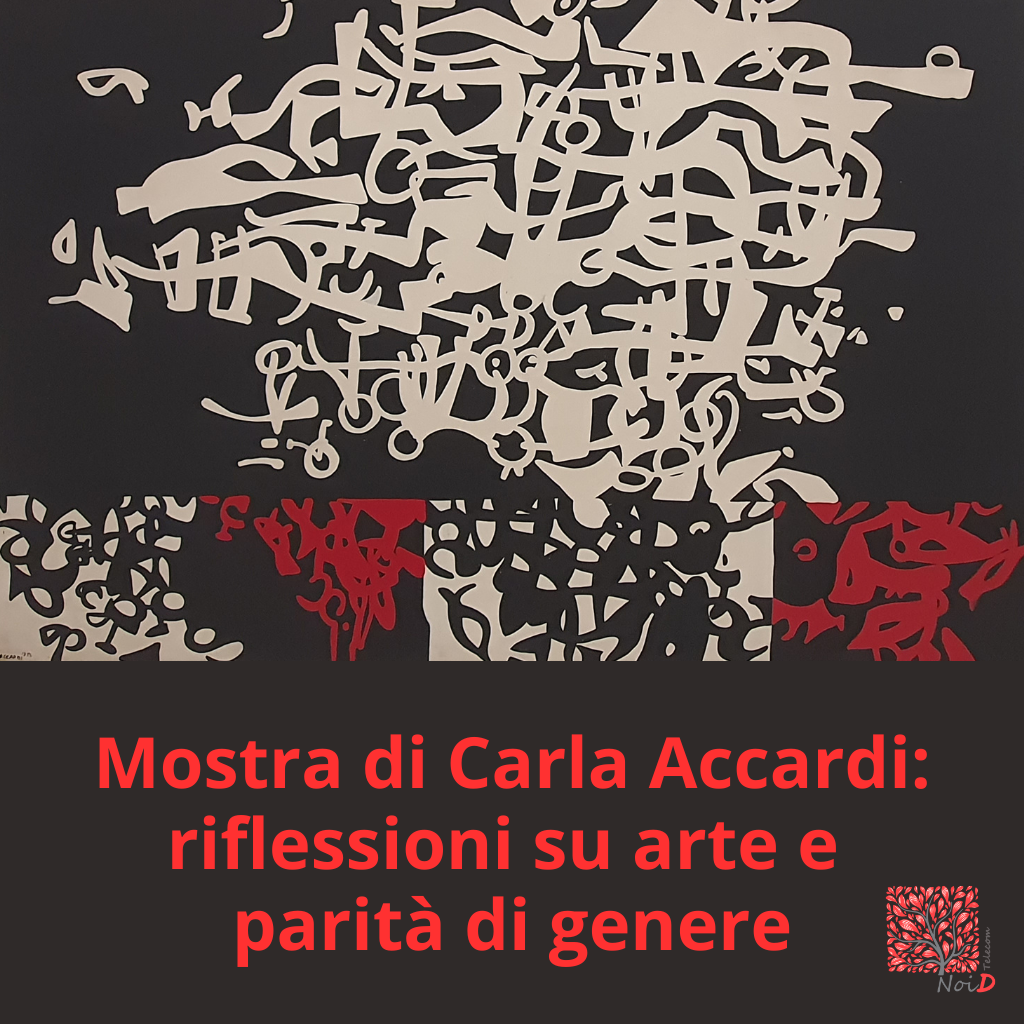Mostra “Io sono Leonor Fini”: un fertile incontro tra forme d’arte ricche di affermazioni identitarie e networking
Con l’obiettivo di creare spazi di incontro autentico e ispirazione condivisa, NoiD Telecom nell’ambito delle iniziative legate al format NoiD Camminiamo, grazie alla preziosa sensibilità ed energia di Stefania Marianna Falzone, ha dato vita ad un nuovo appuntamento di networking culturale, scegliendo come cornice l’universo affascinante ribelle e visionario dell’artista italo-argentina Leonor Fini. La sensazione prevalente durante il percorso non è stata quella di assistere ad una mostra bensì di trascorrere del tempo con qualcuno. Qualcuno che con le sue polivalenti capacità artistiche è stata capace con oltre 100 opere tra dipinti, disegni, fotografie, video, costumi e oggetti, di imbastire in tempi (ancora) più ostili dei nostri una nuova matrice, uno stampo che contraddice il resto del mondo. “Io sono Leonor Fini” è un viaggio esperienziale, nelle sue opere c’è ritmo, inventiva, ambiguità e soprattutto un fertile invito a deporre i bandieroni del tifo per uomini o donne in favore di interrogativi ben più vasti e profondi. La donna, nei suoi lavori, non è musa ma protagonista e la sfinge, uno dei suoi soggetti prediletti in quanto creatura ibrida e potente, è il suo alter ego, rendendo tutto estremamente intrigante e nutriente. Durante la nostra visita abbiamo provato un misto di sollievo, solidarietà, riconoscimento come accade quando si incontra qualcuno che sembra aver davvero imbroccato una vocazione, in questo caso verso l’indipendenza e l’affermazione della propria identità. Un grande esempio e una potente ispirazione per continuare a costruire insieme spazi più abitabili, aperti alla diversità, alle metamorfosi, al coraggio e alla bellezza. Ripercorriamo ora il percorso, grazie al prezioso contributo di Katia Novakova guida d’eccezione dell’incontro. Leonor Fini (1907–1996) è stata una delle artiste più affascinanti e anticonformiste del Novecento, capace di reinventare il surrealismo di Ernst, Breton, Dalì, Mirò ed Eluard donandogli una visione profondamente originale e femminista. Nata a Buenos Aires da madre triestina e padre argentino, si trasferì a Trieste con la madre dopo la difficile separazione dei genitori. Non ricevette una formazione artistica formale. Studiò con Achille Funi al quale fu legata sentimentalmente e col quale si trasferì a Milano dove lasciò testimonianza di sé nel pavimento del Palazzo della Triennale con un mosaico da titolo “La cavalcata delle Amazzoni”. Nel 1933 si trasferì a Parigi, dove conobbe alcuni artisti surrealisti, come Max Ernst, Paul Éluard e Victor Brauner. Pur non unendosi al movimento surrealista che contestava fortemente per la visione maschilista e limitante della donna, cominciò a sperimentarne i metodi e le tecniche. Con Ernst che la definiva “la furia italiana di Parigi” andò a New York dove fu introdotta al MoMA e conobbe e collaborò con i più celebri stilisti del momento, tra cui Christian Dior ed Elsa Schiapparelli. Nel suo periodo romano conobbe Alberto Moravia ed Elsa Morante e frequentò i più esclusivi salotti dell’epoca. Dagli anni ’40 agli anni ’60 lavorò come scenografa e costumista per i teatri di Roma, Londra, Parigi e New York. Complice l’infanzia passata a travestirsi da ragazzo per sfuggire al padre che l’avrebbe voluta riportare in Argentina, Fini ha sempre concepito l’identità come una costruzione fluida e mutevole, una continua rappresentazione di sé attraverso maschere, costumi ed alter ego. Curiosità 🎭 Rifiutò di unirsi ufficialmente al Surrealismo Pur essendo in stretto contatto con i surrealisti – come Max Ernst, André Breton e Salvador Dalí – Leonor rifiutò l’autorità e la visione di Breton e non si considerò mai parte del movimento, difendendo sempre la sua autonomia artistica. La donna non è più una musa, una dea un’ispirazione ma è padrona del suo destino. 🐱 Viveva con oltre 20 gatti Fini era un’amante dei gatti: ne possedeva fino a 23 contemporaneamente, li trattava come creature regali, li vestiva con collari di velluto e spesso li ritraeva nei suoi dipinti. In molte opere sono simboli di potere magico e sensualità femminile. 💄 Teatro, cinema e moda Fini lavorò come costumista e scenografa per spettacoli teatrali, balletti e opere liriche. Creò i costumi per la celebre versione del “Romeo e Giulietta” con Margot Fonteyn e Rudolf Nureyev, e anche per il film cult “La bella e la bestia” (1946) di Jean Cocteau. Fu amica di Elsa Schiapparelli per la quale creò una boccetta a forma di busto femminile per il profumo Shocking ispirandosi alle forme dell’attrice statunitense Mae West. ❤️ Vita privata Rompendo ogni convenzione, Leonor visse per anni con due uomini, Konstanty Jeleński (Kot) e Stanislao Lepri, in una relazione poliamorosa e creativa. Tutti e tre si sostenevano artisticamente, e la loro convivenza era improntata all’arte, alla libertà e alla non gelosia. 📚 Scrisse e illustrò libri Non fu solo pittrice, ma anche autrice e illustratrice. I suoi libri sono popolati da creature androgine, mostri seducenti, donne guerriere, in un immaginario ricco di simbolismo erotico e mitologico. Opere 🎨 l’Alcova (1941) e l’Alcova: interno con tre donne (1939) In questa tela, Fini rovescia la tradizionale iconografia della Venere dormiente: qui è la donna a dominare la scena, seduta su un uomo nudo, passivo e abbandonato. Un’opera che anticipa di decenni le riflessioni sullo sguardo femminile nell’arte e sulla sovversione dei ruoli di genere. Anche “Donna in armatura” (1938) e l’”Alcova: interno con tre donne” (1939) rientrano in questo filone, proponendo una figura femminile ieratica e marziale, vestita di un corsetto metallico che richiama l’iconografia delle amazzoni. Un altro elemento centrale della sua poetica è il travestimento, che emerge in opere come “Ritratto di André Pieyre de Mandiargues” (1932), in cui il poeta appare ambiguamente vestito, sfidando la distinzione tra maschile e femminile. Fini concepisce l’identità come una costruzione fluida e mutevole, una continua rappresentazione di sé attraverso maschere, costumi e alter ego. “l’Alcova” (1941) “l’Alcova: interno con tre donne” (1939) 💄 Lo stereotipo della Venere dormiente: Lo stereotipo della Venere dormiente è un tema ricorrente nell’arte e nella cultura visiva occidentale, che rappresenta una donna nuda o seminuda raffigurata mentre dorme, spesso in una posa languida e idealizzata. Questo soggetto prende il nome da alcune famose raffigurazioni di “Venere”, la dea romana dell’amore, della bellezza e